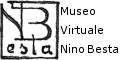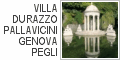portale culturale e turistico per Genova e la Liguria

|
23 novembre 2009
Franco Cardini
Il luglio 1097 segna un punto di partenza: i genovesi sono tra i primi a rispondere
all'appello lanciato da papa Urbano II alla fine del novembre 1095. Una flotta composta
secondo la tradizione da dodici galee e un 'sandalo' parte da Genova alla volta della
Terrasanta. È la risposta all'appello alla prima crociata che allora, naturalmente, nessuno
sapeva fosse tale. I genovesi hanno quindi il primato tra le città italiche per quanto
riguarda la partecipazione alla spedizione che si conclude nel 1099 con la conquista di
Gerusalemme. Ma l' evento è importante anche come punto d'arrivo di una lunga storia
cittadina: l'emergere del libero Comune genovese, l'elaborarsi di una nascente potenza
marittima tirrenica e mediterranea, il costituirsi di un ceto dirigente attorno alla nuova
istituzione della Compagna Communis, come fu chiamata l'organizzazione territoriale di
Genova nel Medioevo. La memoria di quella lontana epopea – legata all'eroe Guglielmo
Embriaco e all'arrivo in città di prestigiose reliquie – e la fondazione di una cronistica
genovese con Caffaro di Caschifellone, avventuriero e scrittore, corrisponde a una delle
pagine più intense e significative della storia medievale italiana, europea e mediterranea.
Franco Cardini
insegna Storia Medievale all'Università degli studi di Firenze
13 11 2009
30 novembre 2009
Michel Balard
1256, Acri, in Palestina: in città scoppia la guerra tra genovesi da una parte, veneziani e
pisani dall'altra. Due anni dopo Genova perde la base per i suoi commerci.
Inizia allora trattative con Michele VIII Paleologo, che mira a restaurare l'impero nella sua
vera sede, Costantinopoli. Guglielmo Boccanegra, capitano del popolo, manda
ambasciatori presso l'imperatore greco e stipula a Ninfeo un trattato innovativo di alleanza
contro Venezia: Genova offre la sua collaborazione militare e navale per restaurare
l'impero greco a Costantinopoli, mentre Michele Paleologo promette in cambio ai suoi
alleati liguri il quartiere occupato dai veneziani nella capitale, il possesso di Smirne e il
passaggio attraverso gli stretti verso il Mar Nero. Nel luglio 1261, prima dell'arrivo delle
navi genovesi, Michele Paleologo conquista Costantinopoli ma mantiene i suoi impegni nei
riguardi dei genovesi, che distruggono con festosa brutalità il palazzo veneziano. Il
capolavoro politico e diplomatico di Boccanegra apre un nuovo episodio dell'espansione
genovese in Oriente: nel 1267 Genova si insedia a Pera, crea nuove colonie in Crimea,
alle foci del Danubio e del Don, ha garantita l'apertura del Mar Nero. Il trattato di Ninfeo dà
il via al 'volo del Grifo'.
Michel Balard
è professore emerito all'Università di Paris - I Panthéon - Sorbonne
13 11 2009
14 dicembre 2009
Giuseppe Felloni
Le guerre con Venezia hanno prostrato le finanze pubbliche genovesi. Per superare una
situazione di sostanziale bancarotta, nel 1405 il governatore francese promuove una
riforma radicale del debito pubblico che si conclude nel 1407 con la creazione di un ente
autonomo. Nasce così la Casa delle compere di San Giorgio, alla quale quasi tutti gli
antichi creditori accettano di trasferire i propri diritti, sia pure ridimensionati. L'anno dopo,
per facilitare le operazioni finanziarie in un momento in cui l'Europa è afflitta dalla scarsità
di monete metalliche, la Casa apre un banco di deposito, giro e credito, in assoluto il primo
del suo genere nella storia finanziaria. Nei decenni seguenti, la Casa delle compere e dei
banchi di San Giorgio assorbe anche i prestiti pubblici rimasti estranei alla riforma del
1407 e il suo ruolo cresce continuamente. La mole ingente dellerisorse finanziarie da essa
gestite ne fa l'interlocutore esclusivo (ma non giugulatorio) dello Stato, cronicamente
bisognoso di denaro, dal quale ottiene in cambio nuovi introiti fiscali e persino la sovranità
su estese porzioni del suo territorio. L'attività bancaria si interrompe nel 1445 ma riprende
con maggior vigore nel 1531, aprendo la strada all'istituzionedi analoghi banchi pubblici in
Italia (dal 1573) e all'estero (dal 1609).
Giuseppe Felloni
è professore emerito dell'Università degli studi di Genova
13 11 2009
11 gennaio 2010
Arturo Pacini
Come nessun altro episodio della vicenda di Genova nell'età moderna, il tradimento e la
tragica fine del conte Gian Luigi Fieschi hanno attratto l'attenzione non solo
degli storici, ma dei letterati, dei polemisti, degli uomini di cultura in genere. Nel corso dei
secoli, la congiura è divenuta oggetto di narrazioni storiche, di testi teatrali e letterari, e
nell'Ottocento di interessanti edizioni di documenti. Oltre che all'importanza dell'evento
nell'Italia del Cinquecento, la fortuna è legata al fatto che la congiura ha i 'tempi del
dramma'; gli 'ingredienti' e i protagonisti sono quelli classici di una tragedia rinascimentale,
adatti a stimolare la fantasia popolare e a solleticare poi la sensibilità romantica. Ma la
congiura Fieschi può essere anche un'utile cartina al tornasole per interpretare le linee
fondamentali dell'evoluzione politica, economica e sociale della città in un secolo di
straordinari cambiamenti. Come in tutte le fasi di rapida e intensa evoluzione, per gli attori
in campo le trasformazioni comportano lenti adattamenti ma anche rovinose sconfitte e
sfolgoranti vittorie: Genova ne emerge come una delle poche città italiane capaci di
conservare le proprie istituzioni repubblicane e come una potenza mondiale in campo
finanziario.
Arturo Pacini
insegna Storia moderna presso l'Università degli studi di Pisa
13 11 2009
18 gennaio 2010
Carlo Bitossi
Tra il 18 e il 29 maggio 1684 Genova subisce un pesante bombardamento, intervallato da
alcuni tentativi da Luigi XIV. È un'aggressione a freddo, malamente mascherata da
pretesti che non convincono nessuno nelle cancellerie d'Europa. L'azione mira a
costringere Genova ad abbandonare il tradizionale orientamento filospagnolo per
diventare un satellite della Francia. Il governo della Repubblica accetta la sfida: resiste
al bombardamento e respinge gli sbarchi. Nei mesi seguenti cerca persino di
contrattaccare. Ma presto la sproporzione delle forze lo costringe a chiedere una
pace all'apparenza umiliante (il doge e quattro senatori devono recarsi a Versailles a
presentare le scuse), che tuttavia salvaguarda l'indipendenza di Genova. Nei decenni
seguenti gli sviluppi della grande politica europea finiscono paradossalmente col fare
proprio della Francia, in maniera indolore e con vantaggio per i genovesi, una delle
potenze di riferimento della Repubblica. Il bombardamento ferisce il tessuto urbano
cittadino, è al centro dei commenti di tutte le diplomazie, ha echi nella cultura del tempo,
mette allo scoperto i nervi della società genovese e contribuisce a orientarne le
trasformazioni.
Carlo Bitossi
insegna Storia moderna presso l'Università degli studi di Ferrara
13 11 2009
25 gennaio 2010
Giovanni Assereto
Impegnatasi, dopo oltre due secoli di neutralità, nella guerra di successione austriaca a
fianco della Francia e della Spagna, la Repubblica di Genova va incontro nel 1746 a
un'occupazione della capitale, tanto umiliante quanto onerosa, da parte delle truppe
imperiali. Mentre i governanti si piegano a tutte le richieste del nemico,
il 5 dicembre la plebe dà il via a una furiosa rivolta. Nel giro di sei giorni, caccia gli
occupanti e crea una sorta di governo parallelo, l'Assemblea del popolo. Su Genova
convergono gli sguardi di mezza Europa. Affascinati dal coraggio dei genovesi, politici e
intellettuali si interrogano sul contrasto apertosi tra la viltà dell'aristocrazia al potere e
l'eroismo del popolo: se la nobiltà non ha difeso la patria e si è mostrata indegna
del proprio ruolo, non toccherà dunque al popolo assumerne l'eredità? Ben presto il
patriziato riesce a riprendere il controllo della situazione e ad accreditare, con un'abile
operazione 'mediatica', una visione unitaria della rivolta. Ma, un secolo dopo, i fatti del
1746 torneranno a caricarsi di un nuovo valore simbolico nel quadro del Risorgimento
nazionale: verrà allora 'inventata' la figura di Balilla, destinata a divenire un topos
dell'immaginario nazionale e un'ossessione degli storici genovesi.
Giovanni Assereto
insegna Storia moderna presso l'Università degli studi di Genova
13 11 2009
1 febbraio 2010
Bianca Montale
L'insurrezione di Genova del marzo-aprile 1849 è l'epilogo di una fase di entusiasmi, di
speranze e di delusioni. Il rapporto tra quella che è stata per secoli una repubblica
indipendente e la dinastia sabauda è stato,a partire dal 1815, non facile. Con la forzata
annessione a un regno di Sardegna tradizionalmente nemico, in una situazione economica
difficile, l'adeguamento alle rigide regole di uno Stato assoluto è lento e non privo di
riserve. Anche quando con le prime riforme civili il clima è sensibilmente mutato, Genova è
rimasta città irrequieta, all'avanguardia nel chiedere più ampia libertà, e motivo di continue
preoccupazioni per il governo di Torino. I genovesi mal sopportano l'essere piemontesi,
ma aspirano, con orizzonti più vasti, ad essere italiani: per questo, a partire dal 1846 e più
nel 1848, ritrovano simpatie e convergenza con Torino in vista della guerra all'Austria. Ma
con il fallimento - per taluni tradimento – dei moti, esasperazione e protesta prendono il
sopravvento fino all'esplosione rivoluzionaria del 1849 e alla durissima repressione: un
trauma che lascia, nel decennio successivo, una traccia profonda. Soltanto l'avvio del
processo unitario contribuisce a mutare sensibilmente l'opinione pubblica genovese.
Bianca Montale
ha insegnato Storia del Risorgimento presso l'Università degli studi di Genova
13 11 2009
8 febbraio 2010
Sergio Luzzatto
Rivoluzionario di professione, Giuseppe Mazzini muore a Pisa da clandestino, il 10 marzo
1872. Appena sette giorni dopo, Genova ospita i suoi grandiosi funerali.
Un'impressionante manifestazione di popolo, decine di migliaia di persone accalcate lungo
il percorso del feretro dalla stazione ferroviaria alla collina del cimitero, da piazza
dell'Acquaverde a Staglieno. Quei funerali di massa significano tante cose: la resistenza
dell'ideale repubblicano nell'Italia dei Savoia trionfanti; la vitalità della Genova operaia e
democratica, pur nella crisi del movimento mazziniano; l'avvento di una moderna politica
dell'immagine, o forse già dello spettacolo. In effetti, i funerali di Mazzini sono straordinari
anche perché il cadavere è stato sottoposto a un trattamento particolare di
imbalsamazione, la pietrificazione. I mazziniani volevano trasformare i resti del leader in
"un monumento di continua rivelazione": un corpo-statua, da venerare religiosamente.
Così, ritrovando la Genova del 17 marzo 1872 ci si scopre ben dentro una storia
italiana (molto italiana) di leader carismatici, santi laici meravigliosi crismi e ineffabili
carismi.
Sergio Luzzatto
insegna Storia moderna presso l'Università degli studi di Torino
13 11 2009
15 febbraio 2010
Antonio Gibelli
Il 5 maggio del 1915 Genova è teatro di un evento chiave della battaglia per portare il
paese in guerra. Nel corso delle celebrazioni per l'inaugurazione del monumento ai Mille,
presso lo scoglio di Quarto, Gabriele D'Annunzio pronuncia un'orazione di grande effetto
davanti a un pubblico acclamante giunto sul posto dopo un imponente corteo cittadino.
L'oratoria dannunziana e la coreografia della cerimonia, caratterizzata da una non
trascurabile presenza popolare e dalla saldatura tra tradizioni garibaldine e opzioni
nazional-patriottiche, forniscono uno dei primi esempi di nazionalizzazione delle masse
attraverso una nuova estetica della politica. Le vicende del 'maggio radioso' segnano la
conquista della piazza da parte delle forze nazionaliste e contribuiscono a far precipitare la
decisione dell'intervento: una decisione, anzi un azzardo che ha enormi conseguenze per
la futura crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo. Non solo questo fa però Genova
protagonista della Grande Guerra: l'Ansaldo è una delle principali aziende mobilitate nello
sforzo bellico, rappresentata come salvatrice della Patria per l'eccezionale sforzo
produttivo nel campo delle artiglierie, in un mito di cui la stessa azienda è artefice
e al quale ancora una volta D'Annunzio dà il suo contributo.
Antonio Gibelli
insegna Storia contemporanea presso l'Università degli studi di Genova
13 11 2009
"Ognuno prevede o tenta di prevedere il futuro. E' parte della vita, degli affari
interrogarsi su quel che il domani porterà, fin dove è possibile ognuno ci
prova. Ma il processo di previsione del futuro deve necessariamente basarsi
sulla conoscenza del passato. Ciò che accadrà deve avere alcune
connessioni con ciò che è già accaduto. E' questo il punto in cui interviene lo
storico. Il quale non persegue il profitto, nel senso che il suo mestiere non
consiste nel mettere a frutto la propria conoscenza per garantirsi dei
guadagni. Ciò che lo storico può fare è tentare di analizzare quali parti del
passato sono importanti, quali sono le tendenze e quali i problemi. Dunque
entro certi limiti, noi dobbiamo fare uno sforzo di predizione, ma essendo
consapevoli del rischio di scimmiottare la preveggenza".
Questa è la storia secondo Eric J.Hobsbawm, uno tra i più autorevoli storici
del nostro tempo. E questa è la sfida del ciclo Lezioni di Storia ideate e
progettate da Laterza.
Grandi studiosi raccontano con un linguaggio accessibile a tutti le date cruciali del nostro passato la cui scelta è strettamente legata alle ripercussioni che le vicende accadute in quei singoli giorni o in quel singolo luogo, hanno avuto sul mondo e sul futuro di ieri, che altro non che è il nostro mondo di oggi. Lo scorrere delle date ci aiuterà, a capire in cosa affondano le nostre radici e quanto complessa e stratificata sia la nostra identità. E' dalla curiosità che nasce il lavoro dell'editore. E dalla curiosità nascono forti passioni. E' forse questa la ragione del grande successo di pubblico delle nostre Lezioni di Storia.
13 11 2009
|